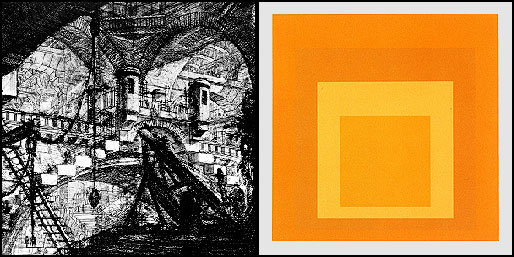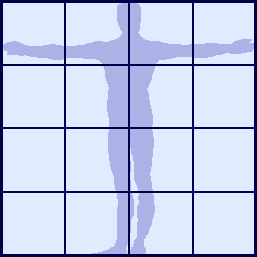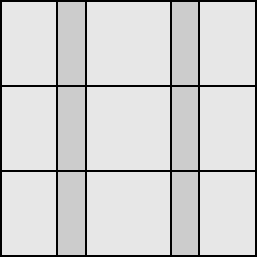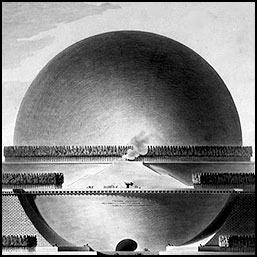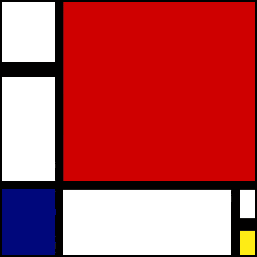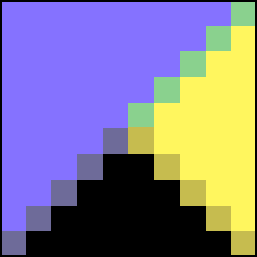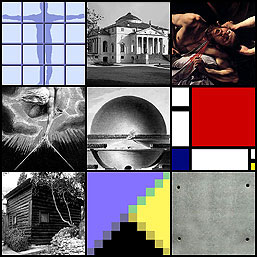Quadrature
minime
Sul senso della misura nell'arte
di Enrico
Cocuccioni

L. Wittgenstein, P.
Engelman - Casa Stonbourough a Vienna - 1926
«Progettare
deve tornare ad essere un atto critico
delle condizioni date, un gesto di resistenza»(1)

Arnold Böcklin
- Odisseo e Calipso (1882) — Giorgio De Chirico - L'enigma
dell'oracolo (1910)
0.0) - Il Muro
e la Scena
La scena raffigurata
nel quadro di Böcklin è definita da due elementi naturalistici:
alcuni scogli in primo piano e una grotta. Lo scoglio è un ostacolo,
un potenziale pericolo per il navigante. Ma qui diventa anche il basamento
su cui si erge la figura di Ulisse, dipinta in una posa "disforica"
che nel linguaggio del corpo è indice di uno stato melanconico, o comunque
di persona ripiegata in se stessa e assorta nei suoi pensieri. La grotta non
è il prodotto di un'arte del costruire ma è forse il più
antico riparo che la natura stessa ha offerto all'uomo. Il simulacro pittorico
dell'eroe greco volta dunque le spalle sia allo spazio rassicurante della
grotta, sia alle attraenti sembianze del corpo seminudo di Calipso, sia allo
sguardo dell'ipotetico spettatore che osservi l'intera scena dal di fuori.
La figura è rivolta verso il mare, o meglio verso un "fuori campo"
che secondo un orientamento alfabetico del senso di lettura del quadro si
potrebbe collocare temporalmente nel passato. Così come la sua postura
può alludere allo spazio mentale di una introspezione nella dimensione
mnemonica e immaginativa del soggetto, più che ad una vigile attenzione
rivolta al paesaggio marino che si profila all'orizzonte (e che il quadro
stesso ci lascia solo intravedere). Questi elementi, per quanto non certo
privi di qualche ambiguità semantica, rendono abbastanza ovvia una
nota chiave di lettura del quadro nel segno del tema romantico della nostalgia
di Odisseo per la propria terra lontana.
Oltre
alla nostalgia dell'artista per la Grecia delle (sue) origini, evocata senz'altro
dalla evidente citazione boeckliniana, L'enigma dell'oracolo di De
Chirico pone in gioco, a partire dal titolo stesso del quadro, il tema delle
connotazioni "divinatorie" dell'ispirazione artistica. Se l'arte
ha in qualche misura una capacità di preveggenza, si tratta allora
di comprendere in che modo la memoria e l'immaginazione, la nostalgia e la
speranza, entrino in scena nello spazio di questa singolare finzione pittorica.
Cosa accade quando l'opera dischiude il sipario su tale inquietante premonizione
"metafisica"? Il quadro ci svela davvero qualcosa del nostro destino,
predice il nostro futuro, oppure induce il pensiero a rifugiarsi nelle fantasie
più bizzarre, o stende un telo scuro sull'attimo fuggevole del presente
con cupe reminiscenze del passato? Leggiamo nel famoso frammento di Eraclito:
«Il Nume, il cui oracolo è a Delfi, non dice né nasconde
ma indica (semainei)». Indica, accenna, significa, fa segno:
le traduzioni del termine semainei sono varie, e tuttavia il senso
del frammento risulta abbastanza "chiaro", posto che in generale
si possa parlare di chiarezza a proposito delle sentenze di questo filosofo,
certo non a caso soprannominato l'Oscuro: è proprio la parziale oscurità
del responso dell'oracolo a mettere in moto la memoria e l'immaginazione del
consultante.
Tali responsi, in
genere, sembrano infatti svelare qualcosa ma anche, nello stesso tempo, nascondere
qualcos'altro. Non si manifestano con proposizioni chiare e distinte, bensì
con frasi spesso altamente ambigue, a doppio senso. Il disvelarsi dell'immagine
lascia dunque sempre un velo coprente o un'ombra scurissima che nasconde qualche
zona dello scenario evocato. Talora la forma del responso è proprio
quella "enigmistica" del rebus da risolvere, della domanda spiazzante.
Date queste premesse, è facile constatare che De Chirico rimane, in
sostanza, fedele a questo repertorio di trucchi del mestiere tipici, da sempre,
di chi esercita la discutibile arte della veggenza. Dai tempi ormai lontani
di Apollo delfico e della Pizia invasata, si può così arrivare
fino alla odierna figura pittoresca della cartomante televisiva, dispensatrice
di precognizioni sibillinne a buon mercato. Ma nel quadro non vediamo alcuna
Sibilla. Il Medium è assente, o forse coincide con l'autore
stesso del dipinto. L'artista sensitivo - il poeta ispirato dal Nume della
pittura - non può che rimanere dietro le quinte del palcoscenico: egli
lascia forse a noi il compito di interpretare i ruoli dei personaggi sulla
scena e il significato complessivo della rappresentazione. Nella prima opera
di Nietzsche, La nascita della tragedia, si trova sostenuta la tesi
che l'artista non sia mai propriamente identificabile nel ruolo di "soggetto":
«...dato
che il soggetto, l'individuo che vuole promuovere i suoi scopi egoistici,
può essere pensato solo come avversario, non come origine dell'arte.
In quanto però il soggetto è artista, esso è già
liberato dalla sua volontà individuale ed è diventato per
così dire un medium, attraverso il quale, l'unico soggetto
che veramente è, celebra la sua liberazione nell'illusione. (...)
Quindi tutte le nostre conoscenze sull'arte sono in fondo completamente
illusorie, perché, come soggetti del conoscere, non siamo un'identica
cosa con l'essere che, in quanto unico creatore e spettatore della commedia
dell'arte, si procura un eterno godimento. Solo in quanto nell'atto della
creazione artistica il genio si fonde con quell'artista originario del mondo,
il primo sa qualcosa dell'essenza eterna dell'arte; giacché in quello
stato egli è miracolosamente simile all'inquietante immagine della
fiaba, che può girare gli occhi e guardare se stessa; in tal caso
egli è contemporaneamente soggetto e oggetto, contemporaneamente
poeta, attore e spettatore» (2).
Nel
testo di Nietzsche, non siamo in fondo molto distanti dalla più tipica
ideologia romantica del genio ispirato. Una ennesima versione di quella concezione
"sacerdotale" dell'arte che sembra peraltro avere radici antichissime.
Ma nello stesso brano viene decisamente negata all'arte ogni funzione "edificante"
(da educazione estetica schilleriana, tanto per intenderci):
«Giacché
soprattutto questo deve essere chiaro per noi, umiliandoci ed esaltandoci,
che cioè tutta la commedia dell'arte non viene affatto rappresentata
per noi, magari per migliorarci e per educarci, anzi che alla stessa stregua
noi non siamo per nulla i veri creatori di quel mondo dell'arte...»
(3).
Sappiamo
che De Chirico, o meglio il personaggio da lui rappresentato nella
scena culturale del suo tempo, aderiva in pieno a questa ideologia tardoromantica.
Come possiamo verificare in una ormai vastissima letteratura critica, i suoi
riferimenti alle opere di Nietzsche, a cominciare appunto da La nascita
della tragedia, sono del tutto espliciti. Talmente espliciti da risultare
sicuramente consapevoli (lo apprendiamo persino, com'è noto,
dagli scritti e dalle dichiarazioni dello stesso De Chirico). Tale consapevolezza
non rappresenta certo un argomento a favore della simpatica storiella dell'artista
ispirato che riceve "rivelazioni" da qualche improbabile Nume destinato
sempre, chissà perché, a rimanere senza nome. E' probabile che
ci sia qualcosa di vero nel chiamare in causa un'alterità non riducibile
all'Io per spiegare il fenomeno dell'ispirazione poetica. L'inconsio psicoanalitico
è uno dei possibili nomi di questo Altro che ci parla a nostra
insaputa. Ma per noi si tratta ora piuttosto di cogliere i modi con cui il
pittore costruisce il suo dispositivo scenico trasformando un piccolo
dipinto qualsiasi in un grande quadro (probabilmente uno tra i più
significativi dell'arte del '900).
Osserviamo
subito che, rispetto al quadro di Böcklin, ora il riferimento all'artificio,
ovvero ad un ambiente costruito, prevale sull'idea di un paesaggio
esclusivamente naturale. Ma se, per ipotesi, ci aspettassimo di trovare raffigurato
un tempio greco, in particolare un tempio dedicato al culto di Apollo, noteremmo
presto che qualcosa non "quadra" nello spazio architettonico dipindo
da De Chirico. Secondo un noto topos letterario, infatti, che troviamo
già in Vitruvio, i Greci edificarono un tempio dedicato ad Apollo ispirarandosi
alle architetture viste nelle città dei Dori e, disegnandone le colonne,
«presero a unità di misura l'impronta del piede dell'uomo, e
lo riportarono in altezza. E poiché avevano riscontrato che il piede
è la sesta parte dell'altezza dell'uomo, applicarono questa proporzione
anche alla colonna, facendola alta sei volte il diametro della base. Così
la colonna dorica rappresentò negli edifici, la proporzione, la solidità
e la bellezza del corpo virile».
Nel
quadro troviamo certo una colonna che, più o meno, potrebbe corrispondere
ad un elemento architettonico di un tempio greco costruito in ordine dorico.
Ma a parte questo modesto indizio, nulla sembra confermare l'ipotesi di partenza.
A meno che tale colonna non abbia nel quadro la funzione retorica di una sineddoche,
ovvero che nel testo pittorico si alluda al tutto (il tempio
di Apollo) attraverso una singola parte, per quanto esemplare (la colonna
dorica, appunto). Tra l'altro, anche La nascita della tragedia, seppure
identifica nella scultura l'arte apollinea per eccellenza (4),
allude ad una possibile declinazione architettonica dell'apollineo, identificabile
precisamente nelle strutture laconiche dello stile dorico: «La musica
di Apollo era architettura dorica in suoni, ma in suoni solo accennati, quali
appartengono alla cetra» (5).
Rispetto
alla scansione verticale del quadro in tre zone principali, la colonna s'interpone
tra l'apertura che si affaccia sul paesaggio e la parte centrale costituita
da un muro in mattoni. Il centro geometrico del quadro cade appunto su questo
muro. Non è affatto scontato, ovviamente, che l'asse ottico di un dipinto
coincida con l'effettivo centro d'interesse dell'immagine in esso raffigurata.
Tuttavia la centralità del muro potrebbe avere qui anche un qualche
significato nell'economia generale dell'interpretazione dell'opera, ammesso
che questo enigma sia davvero interpretabile. Un simile muro in mattoni
non rientra, evidentemente, nell'intera casistica delle costruzioni greche
antiche. Tanto meno, dunque, di quelle basate sull'ordine dorico. Possiamo
quindi supporre che il muro sia più recente della colonna, nonché
della stessa pavimentazione in lastroni di pietra che fa da basamento all'intera
struttura. Siamo perciò di fronte, verosimilmente, ad una stratificazione
di elementi architettonici, ben poco ascrivibile ad una costruzione omogenea,
o realizzata in un ben preciso momento storico, o rispondente ad una determinata
configurazione tipologica relativa ad una specifica destinazione d'uso.
Tale
condizione è tipica di uno sguardo "moderno" sulle permanenze
residuali del mondo "classico". Le città con un nucleo antico,
infatti, presentano analoghe stratificazioni che talora somigliano, appunto,
ad un bricolage surrealista ante litteram. Il trovarsi di
fronte alla visione di qualche frammento archeologico spaesato, riconduce
così il nostro pensiero, ancora una volta, al tema settecentesco e
romantico della nostalgia per la presunta classicità perduta: torniamo
con la memoria, per esempio, alle più note iconografie piranesiane,
oppure al melanconico disegno di Füssli L'artista sgomento di fronte
alla grandezza delle rovine antiche (1778-1780).
In
una recente intepretazione del quadro, è stata poi messa in evidenza
la doppia vocazione, per così dire, dello spazio architettonico rappresentato:
da un lato, il tema del tempio di Apollo non può essere del
tutto abbandonato, dall'altro, esso però va ricompreso alla luce di
un riferimento alla forma tipica del teatro greco. In particolare del suo
porsi, solitamente, come una sorta di terrazza che domina l'orizzonte naturale
di una valle. Tale riferimento, offertoci dallo stesso De Chirico, acquista
un particolare senso proprio alla luce delle numerose considerazioni contenute
in La nascita della tragedia relative, com'è noto, alla centralità
della figura di Dioniso anche per quanto riguarda la comprensione delle stesse
declinazioni apollinee dell'arte greca classica.
Riportiamo
dunque un'ampia citazione tratta dalla puntuale analisi che Riccardo Dottori
ha dedicato al quadro, dove appunto si chiarisce questo aspetto della duplice
valenza simbolica dello spazio architetturale dechirichiano, insieme apollineo
e dionisiaco, per così dire. In particolare, l'autore si sofferma su
alcune affermazioni di De Chirico, contenute nel saggio Sull'arte metafisica,
apparso in «Valori plastici» nel 1919, e in base ad esse formula
la seguete ipotesi:
«...più
che di un tempio si tratta di un portico, di una terrazza; la stanza in
cui si conserva la statua del dio non ha tetto. A dieci anni di distanza
dunque (il quadro datato 1910 era stato iniziato o concepito certamente
già nell'autunno del 1909), l'autore teorizzando la sua estetica
metafisica aveva in mente ancora questo quadro. Le sue esperienze, letture,
idee di allora, che lo avevano portato alla composizione di questo quadro,
formano ancora il nocciolo duro delle sue teorizzazioni di ora, della
estetica metafisica. Ma ciò è anche la prova che le idee
che sono alla base di questo quadro, che sappiamo essere idee nietzscheane,
vengono formulate sulla base della lettura di un'opera ben precisa, e
cioè la Nascita della tragedia, che come sappiamo ha proprio
questo tema, la tragedia della serenità. Il richiamo ad Omero ed
Eschilo ne è una prova ulteriore. Proprio Eschilo è il tragico
preferito da Nietzsche, in quanto rappresenta ciò che di più
originario v'è nella tragedia, che per lui all'origine era soltanto
coro; ed il coro non era 'l'espressione' del pubblico, ma era il pubblico,
poiché, secondo Nietzsche: «... un pubblico di spettatori
quale noi lo conosciamo, era sconosciuto ai Greci: nei loro teatri, con
la loro costruzione a terrazze che si innalzavano per permettere la vista
degli spettatori era possibile ad ognuno sorvolare con lo sguardo l'intero
mondo culturale attorno a sé, e pretendere di essere coreuta».
Nietzsche continua inoltre dicendo: «La forma del teatro greco ricorda
una solitaria valle montana: l'architettura della scena appare come una
luminosa immagine di nuvole, che le Baccanti aggirantesi nella montagna
possono guardare dall'alto, come la grandiosa cornice in mezzo alla quale
ad esse appare Dioniso»; frase che riecheggia in questo quadro,
che è nient'altro che una terrazza su di un monte. Anche la menzione
di Omero è indicativa, poiché l'elemento apollinico che
si contrappone al dionisiaco, in quel contrasto da cui trae origine la
tragedia, si rispecchia per Nietzsche in quella che egli chiama la religione
olimpica, che trova la sua espressione in Omero» (6).
Rimandiamo
dunque il lettore al saggio di Dottori per un approfondimento ulteriore dell'analisi
del quadro. Qui suggeriamo solo di notare che nell'opera le diverse arti sembrano
essere rappresentate in forma emblematica: la pittura potrebbe, ad esempio,
riconoscersi nel paesaggio mediterraneo - incorniciato dal "portico"
- che scorgiamo oltre il telo sollevato dal vento; l'architettura è
identificata dagli elementi che abbiamo già citato, a cominciare dalla
colonna e dal muro in mattoni; la scultura è rappresentata dalla statua
seminascosta dietro il secondo telo scuro; le arti dello spettacolo sono evocate
dai riferimenti già citati al teatro greco e dalle stesse tende scure
che, oltre all'idea del velo di Maia, possono richiamare anche quella di un
moderno sipario; poesia e musica rientrano poi nei riferimenti filosofici
già evidenziati a proposito della dimensione dionisiaca intesa nell'ottica
di Nietzsche. Eppure nessuna sintesi carnevalesca delle arti è possibile
all'interno della visione segregante dischiusa dalla pittura metafisica dechirichiana.
Al centro della scena troviamo pur sempre un muro che impedisce all'ebbrezza
dionisiaca di debordare oltre i rigidi confini prestabiliti dalla disciplina
della pittura. I recinti delle singole discipline non sono dati una volta
per tutte, per legge naturale o divina: sono la posta in gioco sempre rinnovata
di un atto che è, insieme, critico e costruttivo.
La commedia dell'arte tende invece ad invadere lo spazio del quotidiano. Il
culto di Dioniso impone questa illusoria fuoriscita dai limiti della cornice.
L'artista
corre allora il rischio di trasformarsi in giullare, in saltimbanco al servizio
della società dello spettacolo. Il performer è appunto
colui che rimane in bilico, sospeso come un funambolo tra la commedia dell'arte
e il tragico quotidiano. L'installatore è colui che
accetta di trasformarsi in funzionario dell'Impianto. Un cantastorie
ambulante che si rassegna al carattere effimero dei suoi interventi spettacolari.
L'esatto contrario dell'homo faber. Ma il fare arte, oltre a suscitare
orge dionisiache, non implica forse anche la sobrietà di un'arte
del costruire? Non occorre forse anche oggi erigere "muri"
che stiano in piedi e vi rimangano per un certo tempo, possibilmente non troppo
breve? Molte "scenografie" dell'architettura postmodernista sono
già coperte di polvere in qualche deposito di Cinecittà. Ma
L'enigma dell'oracolo è invece ancora lì, appeso a
un muro. Così, se Nietzsche ha mostrato la modernità
del classico, ovvero il suo risvolto tragico, il Nume che ha ispirato
De Chirico ha forse consentito all'artista di sollevare il velo sulla classicità
del moderno, ovvero sul suo centro tangibile, disadorno, poco appariscente,
e tuttavia ben più solido e durevole dei pensosi simulacri nostalgici
che occupano il resto della scena. Ecco allora il futuro che ci attende secondo
l'ambiguo responso dell'oracolo: «muri ancora da abbattere, muri ancora
da costruire».
[Cfr.
Riccardo Dottori, Quid
est rerum metaphysica?]

Tadao Ando - The
Water Temple (1991) [part. architettonico]
«Nelle mie
architetture i muri hanno un duplice ruolo,
perché nello stesso tempo affermano e rifiutano» (7)
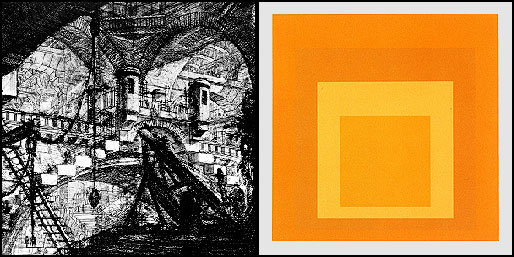
Piranesi e Albers:
nel minimalismo architettonico di Tadao Ando si afferma la corporeità
di un percorso sensoriale pur nella sobrietà di pochi elementi costruttivi
ricorrenti...

Giuseppe Uncini,
Cementoarmato, 1960, iron and cement, cm. 62x61
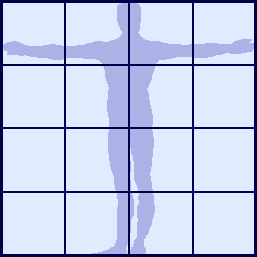
0.1) - La misura
dello spazio
«L'uomo articola
il mondo attraverso il corpo,
e poiché questo possiede un alto e basso, una destra e una sinistra,
un davanti e un dietro, anche il mondo che da esso prende forma
è uno spazio eterogeneo» (8)
Un
foglio di carta completamente bianco, non ancora "sporcato" da alcun
segno, è assimilabile all'idea di uno spazio vuoto, ancora indifferenziato,
privo di qualunque articolazione interna. Ecco dunque un esempio di cosa potrebbe
intendersi per spazio omogeneo. In realtà si tratta di una
semplificazione grossolana: un foglio di carta ha una forma, una dimensione,
un bordo che lo delimita, una superficie materiale che non è mai perfettamente
liscia (e che spesso appare illuminata in modo non uniforme). Inoltre, a sua
volta, tale foglio può apparire orientato in vari modi (in senso verticale,
orizzontale o sgembo) rispetto allo spazio circostante entro cui esso è
pur sempre annidato (ovvero collocato rispetto all'orizzonte visivo
di un osservatore qualsiasi). Qualunque progetto umano non inizia mai a configurarsi
in uno spazio completamente vuoto. Perfino l'Artefice, il demiurgo di cui
parla Platone nel Timeo, non crea il mondo dal nulla, bensì
parte verosimilmente da qualcosa di già dato. Facciamo dunque
finta che il foglio di carta in questione sia uno spazio realmente immacolato,
e proviamo a fare il seguente esercizio. Per prima cosa tracciamo un segno
qualsiasi. Non un segno meditato, ma il primo che capita: la semplice traccia
di un gesto privo di una intenzionalità precisa.
Osserviamo
ora il risultato di questa prima interazione tra il segno generico e il suo
specifico supporto materiale: che cosa è accaduto? Come è cambiato
l'intero campo di relazioni spaziali entro cui siamo immersi? Questa è
più o meno la situazione in cui si trova un architetto quando comincia
un progetto. Già il primo segno tracciato sul foglio rompe l'isotopia
iniziale e orienta le probabili mosse successive, a meno che non sia prontamente
cancellato, magari alla luce di un successivo ripensamento da parte dell'autore.
Un segno di matita, nel suo piccolo, è proprio come un muro
in grado di delimitare un territorio: una sorta di versione in scala molto
ridotta della Grande Muraglia cinese, per intenderci. Il paragone risulta
meno paradossale se immaginiamo tale segno come una semplice linea di confine
rappresentata in una mappa geografica. L'architetto giapponese Tadao Ando
suggerisce alcune riflessioni sul significato del muro nella fase in cui egli
comincia, appunto, ad immaginare un intervento architettonico in un determinato
contesto: «...un singolo muro indurisce, interrompe, si oppone e altera
violentemente lo scenario in cui si colloca, e inizia così a svelare
i segni di una trasformazione che porta all'architettura» (9).
Che
l'architettura abbia sempre a che fare, in qualche modo, con uno spazio "involucrante",
è una tesi ben nota e facilmente condivisibile. Di questo tema, teorici
e storici come Sigfried Giedion o Bruno Zevi, hanno giustamente sottolinato
la rilevanza per una comprensione non superficiale dei problemi critici dell'architettura,
in particolare di quella moderna. Al concetto di spazio è stato poi
accostato quello di luogo, non senza qualche intento polemico: lo
spazio concreto dell'esistenza umana non è infatti mai concepibile
solo in modo astratto, come una pura estensione indifferenziata e quindi priva
di qualità intrinseche, bensì è sempre vissuto come questo
spazio - in parte già dato e in parte da configurare - che
si articola in un peculiare sistema di luoghi (come ha rimarcato, ad esempio,
Christian Norberg-Schultz, riprendendo peraltro il filo della fondamentale
riflessione heideggeriana sul corpo e lo spazio). Luoghi che hanno una storia,
un significato, una vocazione, un genius loci.
Anche
all'interno delle ricerche sulla fenomenologia della percezione, si conferma
l'ipotesi di uno spazio orientato e disomogeneo, proprio
in quanto correlato indissolubilmente con la sfera sensoriale corporea
(oltre che a quella mentale o cognitiva). Quando parliamo di spazio
stiamo dunque sempre evocando delle relazioni, a cominciare appunto dalla
relazione di un soggetto agente e senziente con il proprio
contesto ambientale. Un contesto sempre definito - almeno secondo la pur controversa
teoria di James J. Gibson - dalla tendenziale stabilità di
un determinato layout ecologico, entro cui si muove un osservatore,
il quale, prima ancora di costituirsi o meno come "animale razionale",
riceve già dall'ambiente un flusso continuo e abbastanza "ordinato"
di stimoli percettivi.
Un
mondo fatto, in ogni caso, di superfici materiali più che di entità
geometriche astratte. Se per un animale non umano lo spazio circostante
non si pone, probabilmente, né come pura estensione uniforme né
come un ammasso caotico di stimoli sensoriali, ma come una sorta di Aperto
(nel senso di Rilke), ovvero di scenario istintuale che tuttavia non è
reso intelligibile da alcun ordine simbolico di tipo "metafisico",
per il cosiddetto animale razionale le cose si complicano maledettamente,
dal momento che quest'ultimo sembra poter organizzare le sue esperienze anche
alla luce delle proprie facoltà intellettuali, ad esempio mediante
simboli astratti, convenzioni linguistiche, assiomi geometrici e sistemi di
calcolo. Queste capacità consentono lo sviluppo della tecnica. La tecnica
trasforma infine lo spazio in una griglia geometrica uniforme. E in essa instaura
il proprio dominio. Dalla topologia dell'Aperto si passa così alla
presunzione di uno spazio infinito e omogeneo, interamente organizzabile in
base ai tre assi cartesiani x y z. Reso compiutamente astratto
dal pensiero calcolante, ossia posto in corrispondenza biunivoca con il regno
virtualmente senza limiti del numerabile e del calcolabile. Questa concezione
puramente quantitativa e "catastale" dello spazio non può
non riverberarsi, a sua volta, sull'intera compagine dell'esistenza, ovvero
sull'ambiente fisico reale, con effetti talora disastrosi sulla vita quotidiana
dello stesso homo sapiens.
«Così
potrebbe darsi - scrive Martin Heidegger - che il nostro abitare impoetico,
la sua incapacità di prender la misura, derivi da uno strano eccesso
di furia misurante e calcolante» (10).
Eppure quel vecchio uomo vitruviano con le braccia aperte, inscrivibile nella
forma del quadrato, forse non è solo il patetico emblema dell'umanismo
antropocentrico: il suo senso della misura può includere anche
la consapevolezza dei propri limiti, quale premessa indispensabile di un diverso
sentimento dello spazio. Nell'arte del costruire, il riferimento alle misure
del corpo umano connota, in primo luogo, proprio quella eterogeneità
dello spazio che rende sensibili le differenze tra un luogo
e l'altro, nonché significanti le variazioni di scala
tra le cose. L'architettura presume allora una qualche consapevolezza di queste
singolari quadrature corporee; di questa "metrica senza metro"
che fonda la poeticità dell'abitare. Del resto, che a volte sia
proprio la dimensione di una cosa a fare la differenza,
dovrebbe risultare evidente in qualunque pratica costruttiva. Scrive ad esempio
Vittorio Gregotti:
«Una piramide
in pietra alta 60 metri è un monumento egiziano tra i più
importanti della storia dell'architettura. La stessa forma alta 6 cm,
in bronzo, è un fermacarte. Una piramide di vetro è un lucernario,
se è di paglia diventa una capanna africana. Scala dimensionale,
materia, forma, uso, significato, sono dunque sempre interconnessi nella
definizione di qualsiasi manufatto: dal piccolo oggetto all'organismo
architettonico» (11).

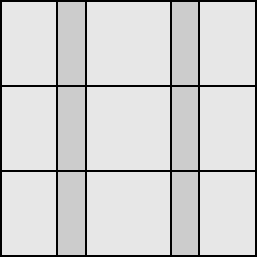
0.2) - Schemi
palladiani
«Il minimalismo
è la più recente incarnazione del classico» (12)
Troviamo
questa ricostruzione ipotetica dello schema generativo tipico delle ville
palladiane nel noto saggio di Wittkower sui principi architettonici dell'età
dell'umanesimo. Nel saggio si approfondisce il significato dell'adozione,
in ambito rinascimentale, di una tipologia basata sulla croce greca (facilmente
inscrivibile nelle forme del quadrato e del cerchio) nel progetto delle chiese.
Al significato "esistenziale" della croce latina subentra una idealizzazione
geometrica dello spazio sacro che impone, per così dire, di concepire
la croce come il tratto fondamentale che unisce il simbolo terrestre del quadrato
con la forma emisferica della volta celeste. Queste forme devono dunque sovrapporsi
perfettamente nell'archittettura sacra. C'è chi nega la possibilità
di ascrivere all'arte del Rinascimento simili preoccupazioni dottrinarie di
ascendenza teologica, ovvero una effettiva aderenza concettuale e stilistica
ai temi religiosi affrontati, in quanto la considera più attratta dal
profano che dal sacro.
Wittkower
mostra invece che nell'uso della geometria e dei rapporti proporzionali gli
artisti cercano rigorosi criteri compositivi che non troverebbero spiegazioni
plausibili senza il riferimento ad un orizzonte di richiami classici e neoplatonici
coniugati con le simbologie religiose della tradizione cristiana. Si potrebbe
obiettare che una prova del significato puramente mondano di tali schemi progettuali
è nel fatto che anche l'uomo vitruviano di Leonardo è inscritto
nel cerchio e nel quadrato. Ma, a ben guardare, nella costruzione del disegno
leonardesco le due figure geometriche non coincidono perfettamente: il realismo
anatomico dell'immagine impone, infatti, di puntare il compasso nell'ombelico,
mentre il quadrato entro cui è inscritta la figura umana con le braccia
aperte risulta sensibilmente fuori asse rispetto al cerchio.
Questo
dettaglio, in apparenza banale, non consente di dedurre geometricamente dal
corpo umano la doppia simmetria della croce greca. Non è dunque l'aspetto
strettamente umano ed esistenziale del Cristo sofferente crocifisso a fornire
lo schema geometrico di base per la tipologia delle chiese rinascimentali,
bensì l'idea metafisica di un perfetto equilibrio tra l'aspetto umano
e divino attribuita al simbolo della croce. Ciò, nel caso dell'architettura
sacra, non implica evidentemente una diretta identificazione dell'umano con
il divino, poiché il soggetto al centro del discorso simbolico resta
la figura del Cristo. Ma certo il discorso cambia espressamente quando anche
l'architettura civile eredita gli schemi in questione, ad esempio con le ville
del Palladio. Qui è la stessa abitazione umana ad essere paragonata
ad un tempio la cui forma, oltre a nascere da un modulo quadrato, accoglie
talora anche la struttura emisferica di una cupola centrale. Ora è
la stessa dimensione laica della vita quotidiana (quella, ovviamente, dei
ceti sociali più benestanti) ad essere per così dire sacralizzata
e messa in particolare risalto come tale. Solo con l'architettura del Protorazionalismo,
agli inizi del '900, questa idealizzazione "assolutistica" dell'architettura
civile sarà veramente abbandonata, seppure all'interno di un analogo
rigore compositivo che talora continua persino ad avvalersi di griglie quadrate
del tutto simili a quelle adottate dal Palladio.
Riferendosi
a talune recenti tendenze minimaliste dell'architettura contemporanea, Renato
De Fusco osserva che il minimalismo è, in fondo, «la più
recente incarnazione del classico». Nello stesso tempo, però,
lo stesso autore sottolinea che «esso costituisce l'unica linea direttamente
riconducibile al Movimento Moderno, in particolare al protorazionalismo loosiano»
(13). Ma qui le due
grandi categorie in questione, ovvero il Classico e il Moderno, appaiono,
per certi versi, tutt'altro che antitetche (proprio come il nostro iniziale
riferimento alla pittura di De Chirico ha tentato di suggerire). Possiamo
dunque ritenere che classicità e modernità possano oggi ricondursi
alla rinnovata esigenza storica, per così dire, di ricercare negli
artefatti umani una sorta di quadratura minima.
La
forma del quadrato sembra infatti assumere una particolare rilevanza e pregnanza
simbolica nelle ricerche artistiche visive dei primi anni del Novecento. Al
punto da provocare la facile ironia degli artisti più conservatori,
ossia più legati nostalgicamente alle formule accademiche ottocentesche
fondate sulla dogmatica osservanza dei principi formativi legati alla tradizione
delle "Belle Arti". Ecco ad esempio cosa scrive, nel 1923, sul periodico
Das Kunstblatt, Paul Westheim, un amico e biografo di pittori espressionisti
come Kokoschka (quindi non appartenente alla schiera dei "conservatori"
in senso stretto) a proposito delle nuove metodologie didattiche in uso presso
la scuola del Bauhaus:
«Il
progresso consiste nel fatto che nelle scuole d'arte applicata gli studenti
si rompono la testa nello stilizzare foglie di cavolo dal vero, mentre al
Bauhaus ci si rompe la testa per stilizzare quadrati da idee. Basta stare
tre giorni a Weimar, e per tutta la vita si avrà la nausea alla vista
di un quadrato. Malevic ha inventato il quadrato già nel 1913. Fortuna
che non lo ha brevettato! L'ideale supremo del Bauhaus: il quadrato individuale.
Il talento è un quadrato, il genio è il quadrato assoluto»
(14).
Queste
ironiche considerazioni non devono però farci perdere di vista i motivi
non banali che stanno al fondo di questa moderna predilezione per la forma
quadrata in molti campi della ricerca visiva. Nell'introduzione del libro
La scoperta del quadrato, Bruno Munari elenca le molteplici occasioni
in cui appare del tutto sensata l'adozione di questa figura geometrica:
«Nelle più
antiche scritture e nelle incisioni rupestri, il quadrato sta a significare
l'idea di recinto, di casa, di paese, di campo. È una forma piuttosto
rara in natura dove la si può trovare nella pirite cubica dell'isola
d'Elba, in qualche cristallo e in alcune strutture che si rivelano al
microscopio elettronico. Nell'architettura di vari popoli troviamo, fin
dai tempi remoti, edifici a pianta quadrata, soprattutto in quelli di
uso collettivo, religioso o di difesa; molti castelli avevano pianta quadrata.
Un reticolo quadrato regola la pianificazione di molte città, ancora
oggi molti architetti costruiscono i loro edifici su pianta quadrata.
Nel campo delle arti visive il quadrato è un modulo spaziale nel
quale o col quale, operatori visuali, ricercatori e sperimentatori trovano
vari modi di strutturare le loro opere. Queste misure, compresa la famosa
sezione aurea, derivano da interventi sul quadrato (...). Nel campo
della grafica il quadrato aiuta a strutturare molti lavori grafici, dai
marchi di fabbrica, ai simboli e ai segnali, dall'impaginazione all'inquadratura
fotografica. In quasi tutto il mondo i caratteri delle lettere dell'alfabeto
sono strutturate su moduli quadrati» (15).

0.3) - Decapitazioni
barocche
«Le baroque,
c'est la régulation del l'âme par la scopie corporelle.
(...) C'était là notre peinture jusqu'à ce qu'on ait
fait le vide en commençant sérieusement à s'occuper de
petits carrés» (16)
Nel
Timeo di Platone è spiegato il motivo per cui il Demiurgo ha
cominciato la creazione del corpo umano dalla testa, ossia dalla parte più
elevata e più simile alla forma stessa del cosmo. Gli dèi, secondo
il racconto platonico, avrebbero imitato la forma circolare del Tutto, vincolando
le due orbite oculari a un corpo sferico:
«I
circoli divini che sono due, gli dèi, imitando la forma dell'universo
che è rotonda, li legarono in un corpo sferico, quello che ora chiamiamo
capo, che è cosa divinissima e domina tutto ciò che è
in noi. Ad esso gli dèi concedettero anche il corpo in suo servizio,
dopo averlo composto, sapendo che esso doveva essere partecipe di tutti
i movimenti, quanti ce ne fossero. Affinché, dunque, il capo, rotolando
sulla terra, che ha altezze e profondità di ogni genere, non si trovasse
in difficoltà nel superare le une e nell'uscire dalle altre, diedero
a lui il corpo come veicolo e capacità di superare quelle difficoltà.
Per questo motivo, il corpo ebbe una lunghezza e produsse quattro membra,
che si possono distendere e ripiegare; e fu un dio a costruire questi strumenti
per camminare, coi quali appigliandosi e sui quali appoggiandosi, esso divenne
capace di procedere per tutti i luoghi, portando sopra di noi la dimora
di ciò che è divinissimo e santissimo» (17).
C'è
un famoso quadro di Caravaggio che ha per tema un racconto biblico, la vicenda
di Giuditta che salva la sua città tagliando la testa a Oloferne, il
capo dei soldati invasori, dopo averlo sedotto e fatto ubriacare. Con la decapitazione
del tiranno Giuditta ha dunque difeso le mura della sua città. Citiamo
dalla Bibbia la parte del racconto che descrive proprio quel climax "liberatorio"
di cui Caravaggio ha potuto evocare il momento decisivo nel crudo realismo
del suo dipinto:
«Giuditta
entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e
si agitò il suo spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione
per lei; già da quando l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla. Le
disse pertanto Oloferne: «Bevi e datti alla gioia con noi».
Giuditta rispose: «Sì, berrò, signore, perché
oggi sento dilatarsi la vita in me, più che tutti i giorni che ho
vissuto». Incominciò quindi a mangiare e a bere davanti a lui
ciò che le aveva preparato l'ancella. Oloferne si deliziò
della presenza di lei e bevve abbondantemente tanto vino quanto non ne aveva
mai bevuto solo in un giorno da quando era al mondo. Quando si fece buio,
i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse dal di fuori la tenda
e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò
al proprio giaciglio; in realtà erano tutti fiaccati, perché
il bere era stato eccessivo. Rimase solo Giuditta nella tenda e Oloferne
buttato sul divano, ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all'ancella
di stare fuori della sua tenda e di aspettare che uscisse, come aveva fatto
ogni giorno; aveva detto infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera
e anche con Bagoa aveva parlato in questo senso. Si erano allontanati tutti
dalla loro presenza e nessuno, piccolo o grande, era rimasto nella parte
più interna della tenda; Giuditta, fermatasi presso il divano di
lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio d'ogni potenza, guarda propizio
in quest'ora all'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme.
E' venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire
il mio piano per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi».
Avvicinatasi alla colonna del letto che era dalla parte del capo di Oloferne,
ne staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, afferrò
la testa di lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore Dio d'Israele,
in questo momento». E con tutta la forza di cui era capace lo colpì
due volte al collo e gli staccò la testa. Indi ne fece rotolare il
corpo giù dal giaciglio e strappò via le cortine dai sostegni.
Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella,
la quale la mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt'e due, secondo
il loro uso, per la preghiera; attraversarono il campo, fecero un giro nella
valle, poi salirono sul monte verso Betulia e giunsero alle porte della
città».
Ogni
profanazione presume l'esistenza di un limite. La messa in scena di un "eccesso"
può dunque essere anche un efficace modo persuasivo per riconfermare
la necessità virtuosa del limite (proprio di quel limite che è
stato oltrepassato dall'atto sacrilego, reso talora in modo assai vivido nella
finzione scenica dell'arte). La psicoanalisi, in particolare con Lacan, si
è interrogata a lungo su questa paradossale economia del godimento.
L'immagine di Oloferne che perde letteralmente la testa a causa della bellezza
di Giuditta, si presta al gioco delle metafore lacaniane relative al tema
della "castrazione". L'arma tagliente della seduzione, intesa anche
come astuzia "artistica", è il preludio che introduce all'acme
narrativo della castrazione simbolica del tiranno (l'evento del capo che perde
la testa, raffigurato nell'attimo più cruento dell'azione drammatica
- il taglio mortale sanguinolento - assume quindi un aspetto particolarmente
macabro, ma in fondo è proprio questa dettagliatissima "oscenità"
carnale a produrre un effetto catartico). Si dirà certo che
il barocco tende al sublime anziché al bello. Ma
anche sul fronte opposto, quello che Lacan indica sommariamente con l'immagine
dei petits carrés (pensiamo in particolare a Mondrian, ovviamente),
non è affatto riducibile ad un'estetica tutta ragionieristica e "apollinea":
possiamo bensì intuire che anche il gesto pittorico con cui l'arte
si è talora liberata, con un taglio netto, della "tirannia"
di ogni mimetismo naturalistico - una illusione di realtà
che include anche questi straordinari tagli di luce del fotorealismo
caravaggesco - può produrre effetti catartici altrettanto potenti.
Prendiamo
il caso dei Tagli di Fontana: possiamo interpretarli, certamente, in
chiave antibarocca, soprattutto se visti come affrancamento dalle ridondanze
materiche dell'Informale, ma possiamo anche, per altro verso, definirli senz'altro
"barocchi" se visti nel loro significato plastico, drammaturgico
e performativo. Posto naturalmente che abbia senso continuare a pensare Classico
e Barocco (il primo riconoscibile per le forme chiuse, il
secondo per quelle aperte, l'uno basato sullo stile
lineare, l'altro su quello pittorico ecc.) come categorie generali
e metastoriche. Occorre comunque rimarcare che, nell'esame delle opere più
paradigmatiche, queste categorie stilistiche finiscono, quasi sempre, per
rivelarsi come semplificazioni del tutto arbitrarie e fuorvianti. La tipica
magniloquenza barocca, ad esempio, è forse una categoria adeguata per
descrivere le opere di Borromini?
«L'architettura
dev'essere per sua natura diffidente nei confronti della ridondanza. (...)
Borromini era un maestro nell'economia dei mezzi espressivi necessari nonostante
la complessità delle sue strutture spaziali, geometriche e tettoniche;
niente è possibile togliere e tanto meno aggiungere alle sue opere,
anche ai frammenti delle sue opere. Questa legge non impone affatto la povertà
ma il senso della misura: la libertà espressiva per apparire deve
apparire secondo misura e necessità» (18).
L'eterogeneità
dello spazio esistenziale e percettivo è in ogni caso la premessa -
ovviamente non di ascendenza cartesiana - anche per comprendere l'architettura
barocca. Rimane, in questo caso, l'idea metafisica di uno spazio infinito,
ma in tale vertiginosa infinitudine l'uomo cerca una piega del tempo, una
curvatura ellittica dello sguardo, un anfratto sensuale da cui lasciarsi accogliere.
Ancora Tadao Ando ci offre uno spunto su questo tema: «Le persone ricercano
una fessura in cui vivere, un intervallo ritagliato nell'uniformità
dello spazio» (19).

0.4) - La trascendenza
del cerchio
«L'uomo, in
quanto è uomo, si è già sempre misurato
rispetto a qualcosa di celeste» (20)
Com'è
noto, solo dopo secolari e innumerevoli tentativi di ottenere con riga e compasso
la quadratura del cerchio ci si è resi conto dell'impossibilità
di trovare una soluzione al problema così impostato. Sappiamo che gli
antichi greci erano in genere poco propensi ad usare forme circolari in architettura
(come ad esempio gli archi, le volte a botte o le cupole, di cui i romani
fecero bensì grande uso) pur conoscendo bene, ovviamente - o forse
proprio per questo - le caratteristiche matematiche del Pi greco.
Il carattere per così dire irrazionale del cerchio è
stato probabilmente intuito sul piano pratico ancor prima che si fosse giunti
ad una esplicita formulazione matematica relativa al significato teorico proprio
dei cosiddetti numeri irrazionali. La divina perfezione del cerchio,
a quanto pare, non è una finalità pratica alla portata dei comuni
mortali: forse neppure un demiurgo platonico saprebbe come realizzare in scala
1 : 1 il cerchio onniavvolgente della volta celeste.
All'uomo
storico, benché capace di ritagliarsi un templum nel cielo
per interrogare i segni enigmatici del proprio destino, una simile possibilità
reale di proiettare nel macrocosmo la forma tonda della propria pupilla sembra
preclusa, almeno per quanto riguarda i gruppi umani più stanziali (le
tende delle popolazioni nomadi spesso hanno invece una forma circolare) condannato
com'è, pressoché da sempre, ad abitare nella immanenza fenomenica
di uno spazio fisico quadrangolare non così facilmente commensurabile
- malgrado i continui tentativi maldestri di far quadrare sempre tutto - rispetto
a quella trascendente "rotondità" dell'Essere evocata dal
buon vecchio Parmenide, la quale però ancor oggi si sottrae alla presa
delle nostre misurazioni empiriche.
Sfera
totalizzante per eccellenza, potenzialmente infinita e onnicomprensiva. Un
cerchio infinito il cui centro sarebbe ovunque e la cui circonferenza non
potrebbe a rigore trovarsi in alcun luogo determinato (per la semplice quanto
decisiva ragione che altrimenti tale cerchio non sarebbe più infinito
ma soggetto ai consueti limiti spaziali di una creatura qualsiasi), secondo
la nota definizione paradossale del divino formulata a suo tempo
da Nicola Cusano (1401-1464). Sappiamo comunque che nel 1882 il matematico
Ferdinand Lindemann pose fine sul piano teorico alla ricerca di una quadratura
del cerchio dimostrando che Pi greco, oltre ad essere un numero irrazionale,
è anche trascendente in quanto non è soluzione di alcuna
equazione algebrica a coefficienti razionali.
Sia
detto qui per inciso, in riferimento all'immagine del Grande Architetto
dell'Universo, chiamata in causa dal quadro di William Blake posto in
apertura del presente capitolo: se qualche dimestichezza con la tradizione
iconologica può essere da noi ancora considerata utile in taluni campi
disciplinari, non intendiamo però riproporre oggi nell'arte le desuete
mitologie di un fondamentalismo tradizionalista che finirebbe per rivelarsi
solo come indice di una patetica "mania di grandezza" storicamente
improponibile. Il mito della Grande Opera è ormai fuori corso. E il
culto del Grande Architetto appare qui solo come una risibile proiezione di
velleità tutte "profane" in una serie di rituali da setta
religiosa che con un autentico misticismo hanno probabilmente poco a che fare.
La corporazione dei Liberi Muratori (ovvero quella lunga tradizione
massonica, depositaria delle più arcane simbologie dell'arte del costruire,
con il suo famoso emblema della squadra e del compasso, con i suoi adepti
segreti, impegnati nella missione impossibile di trasformare, come nel rito
alchemico, la pietra grezza dell'esistenza umana in una sfera spirituale
aurea o perfettamente levigata) non può che sopravvivere
ormai nel limbo romantico delle nostalgie premoderne.
Per
qualche verso, anche il moderno razionalismo critico persegue
analoghe finalità etiche se non persino "edificanti" e talora,
forse, altrettanto visionarie. Ma qui l'ideale regolativo proposto è
quello di una quadratura minima basata sul sentore poetico di una
misura del costruire non del tutto oggettivabile. In ogni caso, non traducibile
direttamente in norme prescrittive senza contraddirne le premesse critiche.
Una visione minimalista, dunque, della razionalità sostenibile. Un
contegno "classico" inteso anche come forma di resistenza propositiva
nei confronti del tragico quotidiano. Come attitudine intersoggettiva
tesa a delineare un decoroso ritegno anti-monumentale nella configurazione
dello spazio civico. Come una sempre rinnovata distanza critica dell'arte
rispetto all'incuria dell'abitare e del costruire odierni. Un modo pacato
ma deciso di opporsi alla ridondanza e, insieme, a quella particolare "uniformità"
che prevale - non già per scelta ponderata ma in base a logiche omologanti
legate a fenomeni di abusivismo o di speculazione - in gran parte delle volumetrie
edilizie contemporanee.
Il
nostro auspicio è che questo atteggiamento non sia un mero residuo
"umanistico". L'ennesima versione di quella ingenua pretesa antropocentrica
che ora l'uomo tecnologico può riproporre addirittura in forma iperbolica,
attribuendo più che mai a se stesso - o magari alla Tecnica - il ruolo
di suprema unità di misura di tutte le cose. Se così fosse,
saremmo di fronte ad un eccesso di presunzione senza precedenti. Ad una "furia
calcolante" che sarebbe l'esatto opposto di quella ritrovata ragionevolezza
costruttiva che si vorrebbe invece proporre come antidoto ai mali ambientali
del nostro tempo.
Saremmo,
in sostanza, di fronte al soggettivismo paranoico di chi si suppone padrone
virtuale dell'intero universo, se non altro in quanto motivato ad agire da
una incondizionata volontà di potenza che non riconosce altra misura
all'infuori della mera quantificazione dei propri successi performativi. Pura
volontà di dominio, dunque, che sarebbe divenuta quanto mai esplicita
nell'epoca della cosiddetta globalizzazione. Forse più che al memento
biblico della Torre di Babele potremmo qui indicare il moderno grattacielo
come forma simbolica che può connotare questa vertiginosa sfida fallica
alle altezze celesti. Scrive a questo proposito Emanuele Severino: «La
cupola esprime la protezione che il cielo immutabile esercita sui mortali
(...); invece il grattacielo trafigge il cielo e la sua immutabilità;
è un assalto al cielo, un tentativo di impadronirsene; ha un carattere
prometeico» (21).
A questo delirio di onnipotenza non è sfuggito neppure lo spirito critico
che animava le visioni del futuro elaborate dagli artisti del Bauhaus. La
conclusione retorica del volantino autopromozionale del 1919, firmato da Walter
Gropius, non lascia dubbi in proposito: «Impegnamo insieme la nostra
volontà, la nostra inventiva, la nostra creatività nella nuova
attività edilizia del futuro, la quale sarà tutto in una sola
forma: architettura e scultura e pittura, e da milioni di mani di artigiani
si innalzerà verso il cielo come un simbolo cristallino di una nuova
fede che sta sorgendo» (22).
Ma
osiamo sperare che il senso della misura qui evocato possa bensì
determinarsi proprio a partire da una più matura consapevolezza (certo,
raggiunta storicamente a caro prezzo e non priva, a sua volta, di risvolti
sublimi) riguardante i limiti medesimi della ragione umana e, quindi,
della stessa progettabilità del mondo.
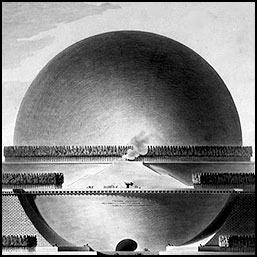
0.5) - L'utopia
della sfera
«...il regno
della geometria come rappresentazione dell'assoluto...» (23)
Dopo
quelle che abbiamo chiamato «decapitazioni barocche» passiamo
ora all'evento storico (1793) della decapitazione del re Luigi XVI. Immagine
anch'essa un po' macabra ma che riassume "plasticamente" il senso
della Rivoluzione Francese molto meglio di un semplice elenco di fatti
storici o di un lungo discorso argomentativo. Enzo Mari sintetizza in modo
icastico, da esperto designer, le sue riflessioni sul significato di
tale evento:
«Simbolicamente
costituiva la definitiva eguaglianza. Ogni diseredato (cioè quasi
tutti) la interpretava, "ovviamente", nel senso di pretendere
anche per sé gli oggetti posseduti dal re. Tale possesso veniva rivendicato
per due ragioni. La prima, esplicita, era il bisogno materiale di un certo
oggetto, ad esempio una sedia. La seconda, implicita, e forse inconscia,
era che la sedia corrispondesse formalmente al trono del re: «Siamo
diventati eguali quindi anch'io sono diventato re». Avrebbe dovuto
sentire (almeno dovrebbe sentirlo oggi): «Siamo diventati eguali e
quindi i troni non sono più necessari» (ma forse si continua
a pensare come allora perché l'eguaglianza non è ancora realizzata
e il progettare sembra non avere altro scopo che dare risposta alle ragioni
inconsce)» (24).
Ma il
Design inteso come moderna disciplina della progettualità consapevole
implica precisamente una critica di tali "ragioni inconsce".
Tale disciplina nasce storicamente, come sappiamo, con la prima rivoluzione
industriale. Non a caso, infatti, continuiamo ad usare questa parola inglese
senza tradurla con 'progetto' o con 'disegno'. Il buon progetto è qui
inteso come l'esatto contrario dello styling, ovvero dell'espediente
stilistico volto solo a rievocare la forma di un "trono" - per riprendere
il felice esempio proposto da Enzo Mari - anche in quei prodotti che con i
"troni" non possono (strutturalmente) aver nulla a che fare. Proviamo
dunque a sintetizzare con una formula l'imperativo etico sotteso dalla parola
design (sullo sfondo di utopie e ideali di chiara matrice illuministica):
«Cerca
di fare tutto il possibile, qui ed ora, per ridurre l'entropia, la ridondanza
informativa, la proliferazione iconica che deriva dalle fantasmagorie della
merce (in quanto tale frastuono semantico può paradossalmente ridurre
la capacità di giudizio e quindi di scelta da parte delle persone).
Cerca inoltre di contrastare, con adeguate strategie progettuali, gli aspetti
alienanti del lavoro umano legati all'uso intensivo - finalizzato al puro
profitto - delle tecnologie industriali, tenendo conto anche delle conseguenze
ambientali negative di questo sfruttamento cieco delle risorse planetarie.
Costruisci dunque la tua "utopia" immaginando un futuro che valga
per tutti noi la pena di essere vissuto e regolati, nel tuo lavoro di progettista,
in base a questa prefigurazione ideale, facendola così retroagire,
in qualche modo, sui nostri attuali comportamenti».
Ma qui
sorge un problema: da un lato la progettualità "forte" ha
bisogno di alimentarsi di grandi visioni utopiche, dall'altro lato c'è
il rischio che questo slancio utopico si traduca nel presente solo nella celebrazione
allegorica del mito di una Ragione dispotica e totalizzante. Bruno Zevi riassume
in questa forma concisa ma efficace l'intera vicenda dell'architettura illuminista,
rimarcandone peraltro l'irriducibile dissidio interno:
«Intorno
al 1760 ogni sistema dottrinario viene sconfessato. (...) La dissacrazione
di contenuti e simboli tradizionali, il proiettarsi verso un futuro dominato
dalla ragione e legato alle scienze si accompagnano ad immagini fantastiche
e utopiche, alla ricerca dell'enorme, dello spaventoso, dell'impossibile.
Abbiamo, da un lato, l'archeologismo dei giganteschi scenari di Piranesi
e, dall'altro, la riduzione a figure geometriche elementari, sfera cilindro
cubo, di Ledoux. Se Lodoli invita al funzionalismo, Boullée disegna
ambienti sontuosi, immani, simmetrici, irrealizzabili per le loro "eroiche",
pletoriche dimensioni» (25).
In
termini architetturali, è possibile distinguere tra un assolutismo
razionalista che esalta la presunta autosufficienza delle forme chiuse totalizzanti
(che ha quindi per paradigma utopico la compiutezza della Sfera) e,
invece, una razionalità minimale che non privilegia le astrazioni
dell'intelletto, non pone alcuna enfasi retorica sul tema dell'autonomia disciplinare,
bensì mantiene un attento dialogo con i materiali e con gli aspetti
funzionali dell'archittettura e, al contempo, cerca di evitare che il gusto
estemporaneo, l'arbitrio formalistico, il mimetismo localistico e il carattere
spesso miope ed effimero del mero funzionalismo edilizio prendano il sopravvento
sulle ragioni di lungo periodo dell'atto progettuale.
Neppure
la funzionalità deve quindi diventare un dogma (ma la critica del Dogma
ovviamente non può, per coerenza logica, assumere a sua volta un tono
dogmatico). In altri termini, l'architettura minimalista non mette su alcun
piedistallo celebrativo né la purezza della forma come tale, né
il dominio incondizionato dell'utilitarismo ingegneristico. La differenza
può essere colta proprio in riferimento all'idea di un senso della
misura: è una questione di scala, di proporzioni, di capacità
di giudizio, di tendenza o meno ad assolutizzare l'ordine geometrico e l'ideale
purezza delle superfici, a voler costruire o meno una sorta di monumento della
Ragione, ad enfatizzare o meno i valori astratti del centralismo e del verticalismo
rispetto ad un effettivo prendersi cura di determinati bisogni collettivi
o individuali disseminati orizzontalmente nel territorio.
Il
gigantesco, la grande scala, l'estasi dello smisurato, non trovano dunque
posto in questo sano atteggiamento riduzionistico che impronta le scelte anche
formali di una certa tendenza dell'architettura contemporanea. Tendenza alla
moderazione, all'autocontrollo espressivo, alla ricerca di una dimensione
progettuale che risulti la meno invasiva possibile. Una tendenza particolarmente
significativa, dunque, ma che per la sua scarsa spettacolarità non
può certo aspirare al risalto mediatico e, quindi, ad una diffusione
su larga scala delle proprie "ragioni" (ma che, forse anche per
questo, merita tutta la nostra attenzione). D'altronde, l'alternativa reale
a queste scarne ipotesi di ritegno classico - ma che nell'architettura
odierna possono trovare preziosi antecedenti proprio nell'ambito del movimento
moderno - rischia di essere solo una rassegnata estetizzazione delle complessità
ingovernabili, del caos edilizio, dell'entropia fatale delle grandi
metropoli, ovvero la mera conferma passiva dell'esistente (come se ormai non
ci fosse più bisogno di demolire o costruire alcunché).
La
presunta razionalità delle forme non può certo trovarsi oggi
nella dimensione faraonica, nell'ordine mummificante delle grandi tombe piramidali
dell'antico Egitto, peraltro costruite non da uomini liberi ma, com'è
noto, da moltitudini di schiavi. Nessun monumento alla Ragion Pura,
dunque, ma un serio, sensibile e ragionevole approccio critico alle
scelte progettuali. In riferimento al particolare tipo di "minimalismo"
che caratterizza le architetture di Ando, Vittorio Gregotti osserva: «Non
si tratta di reinstaurare il regno della geometria come rappresentazione dell'assoluto
(...) ma di restituire significato al gesto originario del porre, disporre,
rilevare, spargere, accumulare, dividere» (26).
Questa
vocazione riduzionistica e antimonumentale non implica dunque il completo
abbandono degli aspetti meditativi, per così dire "metafisici",
legati alla ricerca del significato dei gesti espressivi originari del costruire,
nonché della profondità simbolica, esistenziale o poetica dischiusa
dalla condizione stessa dell'abitare. Tuttavia questi significati trovano
un diverso linguaggio e nuovi materiali attraverso cui esprimersi. Non a caso
anche alcuni grandi pionieri del movimento moderno (come, ad esempio, Frank
Lloyd Wright) hanno spesso trovato una preziosa fonte d'ispirazione nella
tradizione dell'architettura giapponese, nella quale sappiamo che la dimensione
processuale del percorso viene di solito privilegiata rispetto al tema della
verticalità celebrativa. Il che implica anche un diverso modo di concepire
la ritualià o le pause contemplative dell'abitare. Per contro, l'architettura
contemporanea giapponese - ci riferiamo qui soprattutto alle opere di Ando
assunte come esempio - non prevede affatto una contrapposizione rigida tra
le luminose stereometrie del "modernismo" e quell'umile e ombroso
spirito Wabi-Sabi teso invece ad affermare «la bellezza delle
cose imperfette, temporanee e incompiute» (Leonard Koren), ma cerca
piuttosto di bilanciare l'esprit de géométrie con la
sensibilità orientale per le qualità materiche o tattili
delle superfici non levigate.
Occorre,
insomma, tener conto del fatto che un'arte del costruire non può
non rivendicare in qualche misura le proprie ragioni "autoctone".
E non può neppure liquidare del tutto il riferimento etico ad una qualche
"utopia regolativa" che però dovrebbe tradursi, nella pratica
quotidiana del progetto, sempre in termini di critica ponderata e dialogo
civile, senza imposizioni autoritarie e, dunque, atteggiamenti "tirannici".
In ogni caso, il progettista serio non può limitarsi ad esaudire pedissequamente
le richieste del commitente: «Nel dare risposta ad un bisogno, ogni
progetto, se veramente tale, mira a ridefinirlo in modo da ottimizzare o,
anche, modificare i comportamenti di chi esprime quel bisogno. La maggior
parte delle persone, stravolte dalla ridondanza, non sa decifrare prontamente
queste ragioni» (27).
Di qui un compito anche "educativo" in senso lato a cui la cultura
del progetto non può in alcun modo sottrarsi.
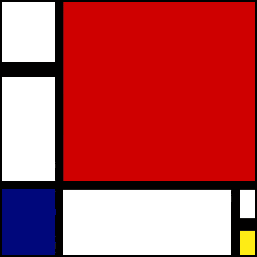
0.6) - Oltre
il tragico quotidiano
«Per Le Corbusier,
proprio come per Mondrian,
il jazz segna il passaggio (...) dell'arte in evento...» (28)
Il
linguaggio della visione
di Gyorgy Kepes è un libro scritto nel 1944 che mantiene ancora oggi
una straordinaria attualità e anzi assume l'ulteriore pregio della
testimonianza durevole e altamente "formativa". Non c'è forse
lettura più stimolante che si possa consigliare a chi desideri una
introduzione chiara e di prima mano ai problemi della moderna comunicazione
visiva in tutte le sue molteplici applicazioni, dalla grafica alla pubblicità,
dal design degli oggetti alle sceneggiature verbosivive per i nuovi
media. L'incipit del libro è un sintomo evidente del momento
storico particolarmente drammatico in cui è stato redatto:
«Intorno a
noi oggi è il caos. Lo spreco di risorse umane e materiali, e l'incanalamento
in vicoli ciechi di quasi tutto lo sforzo creativo attestano l'assenza
di coerenza della nostra vita quotidiana. Nel centro focale di questa
eclissi di una sana esistenza umana sta l'individuo, lacerato dai minuti
frammenti del suo mondo informe, incapace di coordinare le sue esigenze
fisiche e psicologiche. Questa tragica assenza di forma è il prodotto
di una contraddizione nella nostra esistenza sociale e la prova della
nostra incapacità nell'organizzare tutti quei nuovi apporti coi
quali dobbiamo fare i conti se vogliamo mantenere il nostro equilibrio
in un mondo dinamico» (29).
L'idea
che la vita quotidiana dell'uomo moderno sia il regno del caos e dell'informe
a cui l'artista deve saper contrapporre il dominio cristallino della forma,
non è di per sé nuova: in fondo è la vecchia storia di
un Cosmo ordinato che si contrappone al disordine di una materia grezza
e inerte (in quanto si suppone che essa non sia stata ancora fecondata dallo
"spirito" divino, o magari anche solo 'raffinata' dal lavoro umano).
Oppure è la leggenda - altrettanto vecchia - di San Giorgio che sfida
e sconfigge il Drago. Nel Timeo platonico la materia è già
definita come mero ricettacolo: il principio materiale è inteso, appunto,
come alcunché di amorfo, un plesso originario di forme e movimenti
caotici [48 E - 53 B]. Come è facile
intuire, una matrice platonica sopravvive anche nella mentalità del
moderno operatore visivo che, con il suo intervento qualificato, conferisce
un ordine intelligibile a determinati messaggi grazie alla sua capacità
di sottrarli dalla ridondanza della comunicazione ordinaria, ovvero dalla
massa caotica d'informazioni in cui siamo perlopiù immersi nel quotidiano.
Certo però che questa idea stessa dell'artista produttore di ordine
contrasta con una idea opposta, di matrice romantica e altrettanto diffusa:
quella seconda la quale egli produrrebbe piuttosto una destabilizzazione degli
ordini preesistenti. Alla volontà di forma si contrappone così
l'ipotesi della decostruzione, dello scarto creativo rispetto alle norme prestabilite.
Alla chiarezza del messaggio univoco si oppone quindi la sua polisemia, la
sua apertura "poetica", ovvero la sua disponibilità a molteplici
letture interpretative, tutte ugualmente legittime (ma nessuna, a rigore,
davvero esauriente o definitiva).
Insomma,
creazione di un ordine nuovo, oppure distruzione dell'ordine già esistente?
Costruzione o abbattimento di muri? Probabilmente si tratta di due aspetti
complementari della medesima necessità costruttiva. Dipende
allora dal contesto, in base ad un esame della realtà entro cui si
opera, decidere quale sia la via più giusta da seguire: se occorre
cioè privilegiare la cazzuola o il piccone. A volte, infatti, possiamo
trovare i due opposti atteggiamenti nello stesso artista. Prendiamo un caso
limite: poniamo che esista una tendenza artistica d'avanguardia chiamata Dadaismo,
la quale proclami a chiare lettere una volontà dissacratoria, uno spirito
ribelle verso tutte le forme di coerenza logica, di razionalità, di
ordine costuituito nonché di canone artistico da seguire. E supponiamo
che gli aderenti a questa corrente artistica dimostrino con i fatti, con i
loro comportamenti trasgressivi, con i loro bricolage "antiartistici",
la capacità di porre in opera quanto dichiarato a parole nel loro manifesto.
Ebbene, chi affiderebbe mai ad un artista etichettabile come "dadaista"
il delicato compito di rendere coerente e omogenea sul piano visivo la comunicazione
pubblica di un municipio, ovvero di realizzare un progetto sistematico di
grafica coordinata? Eppure tutto questo è realmente accaduto, e con
ottimi risultati:
«Per
quanto possa apparire contraddittorio nella tumultuosa dialettica tra ordine
e disordine che caratterizza le "avanguardie storiche", è
proprio uno dei protagonisti più radicali del dadaismo a porsi come
uno degli attori principali di tali riflessioni sulla grafica come mezzo
di comunicazione e luogo di progettazione. Si tratta di Kurt Schwitters,
inventore di una particolare forma espressiva plastico-pittorica, fondata
sul culto degli scarti e della casualità, del residuale e del frammentario
colto nella quotidianità ed elevato ad arte-fatto. Non a caso, egli
perfeziona lungo l'arco di tutta la sua vita un'ironica filosofia dell'arte,
condensandola con la formula "Merz", etichetta contrassegnante
la sua opera, tanto nell'ininterrotta sperimentazione pittorica che nei
pochi significativi interventi ambientali (noti come Merzbau), quanto nelle
sue attività di grafico e letterista. (...) Nell'ambito della politica
statale di Rationalisierung, la municipalità di Hannover gli affida
(1929-34) il compito di riprogettare la propria identità visiva,
incarico che Schwitters affronta metodicamente (...) Si tratta di uno straordinario
esempio di immagine coordinata pubblica...» (30)
la
Sfera e il Labirinto non sono le uniche due alternative possibili,
sono ipotesi radicali, forse necessarie in talune occasioni, ma che l'arte non
è tenuta romanticamente a perseguire sempre e comunque. L'ordine assoluto
o il disorientamento totale sono solo casi limite che andrebbero appunto considerati
come tali: esiste bensì anche una razionalità intermedia e minimale
del "costruire" che è poi quella con cui affrontiamo in genere
anche i problemi più prosaici della nostra vita quotidiana. L'arte non
può oltrepassare davvero i limiti della cornice: questo muro invalicabile
è ciò che propriamente la distanzia dalla vita vissuta
fuori dal "quadro" (e tuttavia, nel contempo, per uno strano paradosso,
l'avvicina alla superficie medesima della più ordinaria quotidianità,
fosse pure quella di una banale parete domestica). Come già notava Georg
Simmel nel 1902, la cornice delimita, rafforza il limite del quadro,
ma nello stesso tempo stabilisce un rapporto dialogico con il contesto: «L'opera
d'arte è nella situazione intrinsecamente contraddittoria di dover produrre
con il suo ambiente una totalità unitaria, mentre è essa stessa
già una totalità» (31).
Nella presente visione critica, il progetto moderno dell'arte è
dunque, in qualche misura, un orizzonte propositivo che ha raggiunto per noi
un proprio respiro "classico", un significato ancora motivante - anche
sul piano etico - che non resta certo in balia delle mode stagionali o delle
oscillazioni del gusto:
«La verità
è che non possiamo non vivere nel nostro tempo. Ma questo non può
significare rinuncia a un progetto critico; al contrario, vuol dire prendere
posizione dalla parte di chi, oggi, lavora nella direzione di un approfondimento
e di un rinnovamento, di un uso nuovo, appunto, delle nozioni di progetto
e di razionalità. Con la convinzione, tuttavia, che gli strumenti
razionali e la loro incidenza sulle trasformazioni reali hanno perduto
da tempo un ruolo garantito e una definibilità assoluta»
(32)

0.7) - Il mito
dell'ultima casa
«...per tutti
coloro che hanno a che fare con il costruire, continuerà
ad essere un modello l'immagine di una capanna primitiva...» (33)
C'è
una interpretazione critica, tra le più accreditate, che vede nelle
ultime opere di Le Corbusier i segni evidenti di un abbandono delle premesse
razionaliste dei suoi lavori precedenti. Secondo tale ipotesi, questa presunta
fase autocritica sarebbe da ricondurre ad una sorta di crisi nella fiducia
degli strumenti razionali sopraggiunta nella coscienza dell'architetto svizzero
dopo la drammatica evidenza degli orrori della seconda guerra mondiale. Ecco
allora il "gesto informale" della Cappella di Ronchamp che rinnega
i famosi 5 punti della nuova architettura proposti dallo stesso Le Corbusier
nel 1928 con l'esemplare chiarezza programmatica della Villa Savoye. Al confronto,
il ruvido "masso" di Ronchamp sembra invece un evidente omaggio
al repertorio stilistico dell'espressionismo, della topologia barocca o perfino
dell'architettura primitiva.
Difficile
negare questa impressione di fronte all'opera, ma bisogna poi tener conto
della particolare concezione della razionalità del costruire che l'autore
ha reso esplicita in più occasioni, la quale non si limita certo a
guardare l'architettura "primitiva" con l'occhio romantico di chi
vede in essa il regno del buon selvaggio tecnicamente inabile ma dotato di
spontaneità creativa. Si può supporre, al contrario, che Le
Corbusier considerasse tutt'altro che irrazionali anche i metodi costruttivi
più antichi, proprio in quanto li riteneva ascrivibili ad una sorta
di razionalità primordiale, ovvero fondata sul senso della necessità
più che sull'idea della fantasia incontaminata o dell'espressività
ingenua. Joseph Rykwert ha mostrato che l'interesse di Le Corbusier per l'architettura
primitiva è legato alla ricerca di una sorta di archetipo
del costruire, di capanna edenica da cui derivare anche i modelli più
complessi e recenti.
Un
pensiero rivolto alle più remote origini dell'arte del costruire, ai
suoi possibili modelli elementari, come la grotta dei cacciatori paleolitici,
la tenda dei nomadi o la capanna in legno dei primi contadini (da cui si suppone
che sia derivata anche la forma del tempio greco in pietra), ricorre spesso
in varie forme nell'intera storia dell'architettura (34).
Secondo Rykwert, questa ricerca del paradigma perduto non è estranea
al tema mitologico della nostalgia per il Paradiso terrestre. Una nostalgia
che non ha però solo un significato regressivo ma anche propositivo:
il suo risvolto è l'utopia, la promessa di un paradiso futuro. Tale
"sindrome da utopia" può rivelarsi assai pericolosa, può
alimentare forme di fondamentalismo e gesti di intolleranza o di arroganza.
Ma
è difficile pensare che una progettualità radicalmente innovativa,
o ispirata da forti motivazioni etiche, possa affrancarsi del tutto da una
qualche appassionata ricerca di modelli nel passato (anche nel passato più
remoto), nonchè dalla tendenza visionaria a proiettare l'immaginazione
verso un futuro che, sul piano della cautela realistica, non può che
apparire troppo lontano e improbabile. Così, ecco che il mito della
casa originaria finisce, paradossalmente, per risolversi nella visione escatologica
dell'Ultima Casa. Sappiamo inoltre che Le Corbusier si era costruito
una piccola casa in legno (3,66 x 3,66 metri) in una località marina
sulla Costa Azzurra. Un rifugio per le vacanze, ma anche un frugale "pensatoio"
per progettare e dipingere. Muore proprio lì, a Cap Martin, durante
un bagno in mare, a causa di una crisi cardiaca, alle ore 11 del 27 agosto
1965.
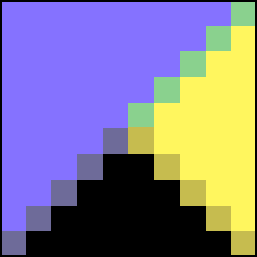
0.8) - Inganni
digitali
«Se osservo
questo monitor illuminato a livello medio da una
distanza di 1,5 m ogni pixel proietterà un'immagine sulla mia
retina di forma quadrata con lato eguale a 0,003 mm:
esattamente a livello della mia risoluzione visiva» (35)
Nella
seconda metà del Secolo XX abbiamo assistito alla nascita e alla diffusione
delle arti elettroniche. Anche grazie a questa rivoluzione tecnologica, molti
muri - sia simbolici che reali - sono stati demoliti o sono caduti per qualche
improvviso cedimento strutturale. Nel mondo dell'arte si sono affermate nuove
modalità espositive: oggi le "installazioni" sono una presenza
rilevante nella grandi rassegne d'arte contemporanea, ma bisogna sottolineare
che il videowall non ha certo rimpiazzato completamente i muri tradizionali.
Inoltre, definire l'arte elettronica immateriale può far sorridere
chi ha visto la cura con cui un pioniere della videoarte come Nam June Paik
dispone, dietro ai suoi videowall, una serie di ventilatori per evitare
il surriscaldamento degli apparati tecnici necessari al funzionamento dell'opera.
Senza dubbio, il cyberspace digitale appare concettualmente diverso
dallo spazio concreto delle arti plastiche tradizionali.
Ciò
non significa, tuttavia, dover prendere troppo sul serio la nota teoria albertiana
- quella della pura forma che agisce sull'animo umano seclusa omni materia
- nella sua ennesima versione moderna: l'ordine geometrico della facciata
di Santa Maria Novella avrà certo un significato metafisico, ma le
qualità sensoriali degli intarsi marmorei ne costituiscono pur sempre
il prezioso supporto materiale. Anche nell'uso del video e del computer gli
artisti hanno sovente mostrato un particolare interesse proprio per le specifiche
qualità sensoriali dell'immagine elettronica. Le tecniche multimediali
hanno in questi anni favorito la produzione artigianale di opere complesse
che spesso uniscono immagine, suono, movimento e interattività, nell'economia
di un singolo artefatto espressivo. Lavori destinati talora in modo esclusivo
ad una fruizione telematica, o comunque "altra" rispetto ai canali
tradizionali dell'arte.
Curiosamente,
però, nel promuovere sul piano ideologico questi fenomeni, non si tiene
quasi mai conto della banale ma non certo irrilevante circostanza che, anche
nel caso dell'arte in rete, senza gli appositi terminali (l'ancora
ingombrante "ferraglia" hardware), nonché senza
un minimo di competenza specifica, non è possibile accedere o participare
a tali esperienze creative, per quanto esse si svolgano nel cosiddetto spazio
virtuale o cibernetico, ossia in un ambito comunicazionale idealmente "free",
aperto a tutti, in teoria privo di barriere fisiche, culturali o geografiche.
Anche nelle arti elettroniche troviamo poetiche per così dire minimaliste
che non si lasciano sedurre dalla retorica neobarocca dell'effetto speciale
sempre più sofisticato e stupefacente. Gli artisti digitali, infatti,
sono consapevoli dei limiti strutturali del "materiale" che usano.
Tali artisti non lavorano solo con delle astrazioni numeriche, ma sono pur
sempre costretti a misurarsi anche con determinati supporti concreti.
Il
pixel (uno di quei minuscoli quadrati che compongono il mosaico
dell'immagine sui monitor informatici) è infatti, alla lettera,
l'elemento pittorico di base nei lavori della cosiddetta computer
art. Talora, dunque, sono gli autori stessi a mettere in primo piano,
con un sano riduzionismo analitico, gli elementi costitutivi delle proprie
costruzioni digitali. In quanto artigiani che conoscono bene la loro materia,
questi autori comprendono anche l'insensatezza della ricerca iperrealista
di una definizione sempre più alta delle immagini digitali:
un inutile spreco di risorse, degno di miglior causa, se pensiamo che la risoluzione
di una comune immagine televisiva, se osservata dalla ragionevole distanza
di circa 3 metri, coincide già con il limite massimo di risolvenza
dell'occhio umano (36).
Nell'immagine
posta all'inizio di questo capitolo, vediamo un piccola porzione notevolmente
ingrandita del mosaico digitale. Il dettaglio evidenzia la costitutiva incapacità
delle immagini digitali di rappresentare linee curve o diagonali. Problema
a cui, nella pratica infografica, si cerca di porre rimedio con espedienti
di vario genere. Il "profano" di solito ignora tali problemi, dato
che ovviamente si basa su quel che vede a livello macroscopico e non su ciò
che risulterebbe visibile solo grazie all'uso di una lente d'ingrandimento.
Del resto, l'occhio si lascia spesso ingannare volentieri. Ma sul piano analitico
bisogna essere consapevoli del fatto che, per così dire, la quadratura
del cerchio resta impossibile anche con l'uso delle più sofisticate
tecniche digitali.
In
un articolo pubblicato nel 1992 sulla rivista Flash Art, proponevo l'ipotesi
di «uno spazio teorico dove si verifica l'integrazione tra cultura
del progetto e strategie della messa in scena, nel quadro delle nuove tecnologie
della comunicazione» (37).
Da un lato, dunque, la logica costruttiva dell'oggetto, dall'altro la dimensione
spettacolare dell'evento. Le discipline del design e le strategie della messa
in scena: due territori operativi profondamente diversi ma che, proprio in
virtù dello sviluppo delle tecnologie multimediali, tendono necessariamente
a convergere. Una vera integrazione tra discipline così diverse, ovviamente,
non è affatto garantita: è assai difficile, insomma, essere
nello stesso tempo abili costruttori e bravi registi, esperti muratori e agili
danzatori.
Nel
frattempo, abbiamo verificato che quelle previsioni teoriche, benché
formulate prima dello sviluppo concreto, su larga scala, del fenomeno Web-multimedia,
non erano affatto azzardate bensì fin troppo realistiche: oggi, in
effetti, gli architetti parlano sovente - persino a sproposito - di "ambienti
virtuali", mentre nelle produzioni multimediali si utilizzano sempre
più - persino, talora, in modo poco pertinente - le tecniche di simulazione
grafica con cui l'architetto o il designer visualizzano, per effettive necessità
pratiche, i propri oggetti da costruire. Con il senno degli oltre dieci anni
trascorsi dopo la stesura di quell'articolo, credo sia giunto il momento di
chiedersi se l'ago della bilancia non sia ora spostato troppo nella direzione
dell'evento performativo e della spettacolarità effimera, dato che
nel frattempo il fantasma della persistenza dell'opera sembra essersi già
dileguato lasciando il campo sgombro da ogni residuo durevole. E se, dunque,
non sia il caso di ripensare, in termini più ponderati e costruttivi,
le modalità odierne di questi continui - e non sempre giustificati
- sconfinamenti disciplinari (seppure divenuti ormai, in qualche misura, inevitabili).
C'è poi un serio problema di metabolismo culturale in campo creativo:
talora ci viene il sospetto che il frenetico avvicendamento delle novità
tecnologiche non lasci purtroppo un tempo adeguato all'artista per approfondire
davvero le peculiarità espressive dei nuovi media di cui si trova a
fare uso.
A
proposito dei nuovi media e in conclusione di un suo famoso libro, Gombrich
lanciava il seguente ammonimento: «Occorre tempo affinché un
sistema di convenzioni si cristallizzi in modo che ogni sottile variazione
abbia la sua importanza. Forse avremmo maggiore probabilità di raggiungere
un nuovo linguaggio formale se fossimo meno ossessionati dalle novità
e dal cambiamento. Sovraccaricando il sistema perdiamo il sostegno del nostro
senso dell'ordine» (38).

0.9) - Il modulo
materiale
«Senza materia
nessuna immagine» (39)
La
logica del modulo è quella della sua riproducibilità infinita.
Oggi le tecniche digitali realizzano questo antico desiderio di ottenere una
replica del tutto identica rispetto al modello originale da
cui è tratta. Un sogno che forse ha cominciato a realizzarsi su larga
scala solo con l'invenzione degli alfabeti. Ma gli alfabeti, come sappiamo,
sono dei sistemi notazionali: ogni lettera è un tipo, una
classe di tratti differenziali, un modello che può generare una serie
potenzialmente infinita di occorrenze concrete, una forma che si
può dunque declinare in tante maniere diverse, adattabile alle grafie
più personali o ai supporti più svariati. Le tecniche digitali
consentono invece la duplicazione perfetta e virtualmente illimitata di ogni
segno.
Ma
così come ogni lettera dell'alfabeto è sempre, nello stesso
tempo, materiale e immateriale, analogamente, non c'è immagine
digitale che possa risultare percepibile in assenza di determinati supporti
materiali. In campo progettuale, le unità di misura adottate (ad esempio,
il metro quadrato), sono ovviamente indipendenti da ogni materia: un metro
cubo di paglia e uno di piombo non sono, in questo senso, concettualmente
diversi: si tratta pur sempre di un cubo il cui lato misura un metro. L'aspetto
sensoriale non conta, non influenza la misurazione. Una griglia geometrica
modulare può essere dunque applicata a qualsiasi cosa: in un foglio
di carta quadrettata si possono disegnare tranquillamente anche delle linee
curve. In architettura possiamo poi distinguere tra schemi tipologici e moduli
costruttivi. Un battistero a pianta ottagonale è una tipologia, un
mattone è invece il più banale esempio di modulo costruttivo.
Il battistero può poi essere realizzato in molti modi diversi, così
come una casa in mattoni.
Nella
moderna standardizzazione industriale le cose vanno in modo un po' diverso:
un edificio prefabbricato tende necessariamente a basarsi su schemi ricorrenti
che offrono al progettista solo una ristretta gamma di possibilità
combinatorie, a meno che anche il modulo prefabbricato non sia di volta in
volta progettato ad hoc, ma questa opzione tende a ricondurre il
prefabbricato alla scala minima del prototipo artigianale, non certo a quella,
ben più vasta ed economicamente vantaggiosa, del modulo industriale
vero e proprio. In questo saggio abbiamo spesso fatto riferimento ai metodi
progettuali di Tadao Ando, assunti come esempio di un particolare approccio
"minimalista" che coniuga sapientemente le istanze tecnologiche
del moderno con una sorta di spirito Zen tipico dell'architettura giapponese.
Sappiamo
che Ando assegna una importanza fondamentale solo ad un numero estremamente
ridotto di elementi costruttivi (che infatti ricorrono spesso nelle sue realizzazioni,
al punto da diventare quasi una "firma" implicita delle sue opere).
Lo stesso Ando dichiara: «Le mie costruzioni sono caratterizzate da
un numero limitato di materiali che esibiscono le proprie qualità»
(40). Forma
e materiale non sono infatti separabili nella sua concezione del
modulo costruttivo. Anzi, più che di moduli, qui si tratta in effetti
sempre di prototipi, come si evince anche dalle sue parole «Ciò
che mi sforzo di produrre non sono astrazioni ma prototipi spaziali»
(41).
L'insegnamento
che possiamo trarre da questo esempio è che in fondo l'arte del costruire
resta pur sempre una pratica artigianale anche in un contesto tecnologico
particolarmente sviluppato come quello giapponese. Se ogni progetto è,
anche nelle pratiche reali odierne, un manufatto, ovvero è
in sostanza la costruzione di un prototipo, ne segue che l'avvicendamento
frenetico delle novità tecnologiche non può "sconvolgere"
più di tanto quei ritmi di lungo periodo che qualificano le esperienze
progettuali più mature e consapevoli. Persino in quei settori del design
che sembrano, per definizione, più coinvolti nelle logiche della produzione
industriale, bisogna comunque prendere atto, oltre alla natura essenzialmente
artigianale che continua a caratterizzare la fase ideativa, anche del fatto
che la stessa produzione seriale di molti "oggetti di design", tra
i più riusciti e significativi, resta perlopiù confinata entro
dimensioni quantitative relativamente trascurabili rispetto al metro statistico
dei grandi consumi di massa. Occorre infatti «ribadire che quasi tutta
la produzione design non è di tipo industriale ma, nella sostanza,
è produzione artigianale connotata industrialmente» (42).
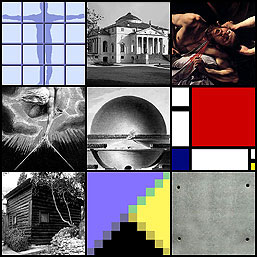
Riepilogo visivo...
In
questo testo abbiamo tentato d'illustrare brevemente le ragioni storiche e
teoriche della persistenza, nell'arte contemporanea, di una vocazione progettuale
- insieme «classica» e moderna - che si manifesta esemplarmente
nella forma di una «quadratura minima» nell'ambito del costruire.
Si tratta di un senso della misura in grado di ricercare alternative
praticabili sia al verticalismo fondamentalista che allo spettacolarismo tecnologico,
sia alle stravaganze egocentriche prive di ritegno civile che alla mera uniformità
tipologica (seppure talora mascherata con abiti cangianti). Una dimensione
critica e poetica che però, proprio per queste sue caratteristiche,
non è traducibile direttamente in formule prescrittive o norme generalizzabili.
Speriamo di essere riusciti, almeno in parte, ad argomentare i motivi di una
nostra personale scelta critica operativa. Una scelta che è, al contempo,
etica ed estetica.
Roma, 26 Settembre 2003
Note
(1)
Francesco Dal Co, Tadao Ando, le opere, gli scritti,
la critica. Electa, Milano 1994, p.450
(2)
Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia,
Adelphi, Milano 1972, pp.44-45
(3)
Ivi, p.45
(4)
Ivi, p.21
(5)
Ivi, p.29
(6)
Riccardo Dottori, Quid
est rerum metaphysica? (http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/a-dottori01.htm)
(7)
F. Dal Co, op.cit, p.449
(8)
Ivi, p.453
(9)
Ivi, p.445
(10)
Martin Heidegger [1954], Saggi e discorsi, Mursia,
Milano 1976, p.136
(11)
Vittorio Gregotti, Sulle orme di Palladio. Ragioni e
pratica dell'architettura, Laterza, Bari 2000, p.108
(12)
Renato De Fusco, Storia dell'architettura contemporanea,
III ed., Laterza, Roma-Bari 2000, p.688
(13)
Ivi, p.691
(14)
Hans M.Wingler, il Bauhaus, Feltrinelli, Milano
1972, p.128
(15)
Bruno Munari, La scoperta del quadrato, Bologna,
Zanichelli 1978, p.5
(16)
Jacques Lacan, Le Séminaire XX, Encore, Paris,
Editions du Seuil, 1975, p.105; tr.it Il Seminario. Libro XX: Ancora,
Einaudi, 1983: «Il barocco è la regolazione dell'anima attraverso
la scopía corporea. (...) Questa era la nostra pittura fino a che non
si è fatto il vuoto, cominciando a occuparsi seriamente di quadratini»
(p.116).
(17)
Giovanni Reale (a cura di) Platone. Tutti gli scritti,
Bompiani, Milano 2000, p.1372
(18)
V. Gregotti, op.cit, p.141
(19)
F. Dal Co, op.cit, p.477
(20)
M. Heidegger, op.cit, p.131
(21)
Emanuele Severino, Tecnica e architettura, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2003, p.113
(22)
H. M.Wingler, op.cit, p.63
(23)
F. Dal Co, op.cit, p.507
(24)
Enzo Mari, Progetto e passione, Bollati Boringhieri,
Torino 2001, pp.10-11
(25)
Bruno Zevi, Architettura, concetti di una controstoria,
Tascabili Economici Newton, Roma 1994, pp 57-58
(26)
F. Dal Co, op.cit, p.507
(27)
E. Mari, op.cit, p.59
(28)
Filiberto Menna, [1962] Mondrian. Cultura e poesia,
nuova ed., Editori Riuniti, Roma 1999, p.129
(29)
Gyorgy Kepes, Il linguaggio della visione, Edizioni
Dedalo, Bari 1971 - 1990, p.15
(30)
Sergio Polano, Pierpaolo Vetta, Abecedario.
La grafica del novecento, Electa, Milano 2002, pp.101-102
(31)
Georg Simmel, Il volto e il ritratto. saggi sull'arte,
Il Mulino, Bologna 1985, p.108
(32)
Filiberto Menna, Il progetto moderno dell'arte,
Giancarlo Politi Editore, Milano 1988, p.79
(33)
Joseph Rykwert, La casa di Adamo in paradiso, Adelphi,
Milano 1972, p.220
(34)
Ivi, (Questa è appunto la tesi ampiamente documentata
nel libro di Rykwert).
(35)
Ruggero Pierantoni, Verità a bassissima definizione.
Critica e percezione del quotidiano, Einaudi, Torino 1998, p.84
(36)
Ivi, p.85
(37)
Enrico Cocuccioni, «Videodesign, il nuovo progetto
dell'arte», in Flash Art, Anno XXV - N.166 - Febbraio/Marzo
1992, pp 182 - 184
(38)
Ernst H. Gombrich, Il senso dell'ordine. Studio sulla
psicologia dell'arte decorativa, Einaudi, Torino 1984; nuova ed. Leonardo
Arte, Milano 2000, p.326
(39)
R. Pierantoni, op.cit, p.39
(40)
F. Dal Co, op.cit, p.451
(41)
F. Dal Co, op.cit, p.444
(42)
E. Mari, op.cit, p.57